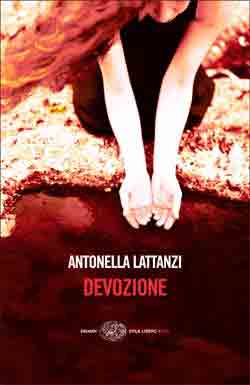è occasionale, non prevede di per sé alcuna continuità, alcun patto terapeutico,
è un’opportunità che può essere utilizzata o ignorata.
È proprio dalla scelta autonoma di aderire al contatto che deriva la significatività
intrinseca di un eventuale incontro.
L’utente, l’altro, assume il ruolo di soggetto attivo, definisce se stesso, cercando
il contatto: afferma la propria esistenza; analogamente l’operatore propone se stesso.
Lo scambio comunicativo in atto si connota come uno scambio intersoggettivo:
presenza e riconoscimento di due soggetti, di due persone nella loro
globalità. Nel frammento relazionale, entrambi i soggetti mettono in gioco
la totalità della loro persona; al di là del contenuto dello scambio comunicativo,
ciascuno dei due soggetti afferma la propria esistenza ed esiste in quel
determinato modo per l’altro; è se stesso con la sua storia; è quindi possibile
cogliere nel contatto relazionale breve e fragile quella specifica presenza umana
nel suo soggettivo modo di essere nel mondo, nel “qui e ora” della situazione.
Approccio fenomenologico dunque che attraverso una conoscenza intuitiva
e immediata consente l’incontro di due soggetti nella loro globalità; consente
di valorizzare il frammento relazionale per incontrare la totalità della
persona, per “cogliere l’essenza attraverso una presa di coscienza immediata” (Binswanger, 1990).
L’approccio fenomenologico si coniuga con la filosofia della Riduzione del danno ridefinendo
la relazione di aiuto, operatore/utente, come una relazione intersoggettiva propria delle okness.
Tipico delle psicoterapie umanistiche, secondo cui l’altro, il tossicodipendente, è riconosciuto
Tipico delle psicoterapie umanistiche, secondo cui l’altro, il tossicodipendente, è riconosciuto
come persona rispetto alle sue esigenze; si dà fiducia al suo modo di vedere la realtà.
Tale visione positiva della persona e delle sue risorse sottolinea un approccio profondamente etico che richiama la teoria berniana dell’ “il paziente possiede una pulsione innata verso la salute, sia in senso mentale che fisico” (Berne, 1966).
Tale visione positiva della persona e delle sue risorse sottolinea un approccio profondamente etico che richiama la teoria berniana dell’ “il paziente possiede una pulsione innata verso la salute, sia in senso mentale che fisico” (Berne, 1966).
In tale ottica, la relazione di aiuto si connota come atteggiamento consulenziale
che non impone scelte e modelli, ma è finalizzato a sviluppare consapevolezza, a riconoscere e potenziare risorse, e competenze presenti; atteggiamento consulenziale per facilitare scelte autonome, per recuperare il senso degli eventi; ancora dunque atteggiamento etico finalizzato a promuovere autonomia di pensiero e di azione; protagonismo anziché adattamento.
La relazione di aiuto nell’incontro in strada come occasione di attivare e
sperimentare una relazione intersoggettiva attorno a un
evitare rischi (buco pulito, sesso sicuro, overdose), prendersi cura
della propria salute, della propria vita; l’attenzione sul contenuto, ma soprattutto
sul processo: sul come si attua lo scambio relazionale.
L’incontro in strada breve, apparentemente povero e riduttivo, costituisce
un’esperienza relazionale forte, di riconoscimento reciproco, di riconoscimento
“dell’altro”, delle sue risorse e competenze; un’esperienza relazionale
correttiva rispetto a esperienze precedenti “di dipendenza”, di adattamento
o ribellione, a esperienze a volte antiche, a volte recenti e ripetitive
con i servizi, le istituzioni, con il mondo in generale.
Il contatto operatore/utente in strada può costituire un’esperienza relazionale
nuova, non assistenziale, un’esperienza significativa per percepire
una diversa immagine del sé, per sperimentare un diverso modo di essere nel mondo.
In tal senso, occorre mantenere una chiarezza metodologica negli interventi
dell’Unità di strada per salvaguardare la significatività della relazione operatore/utente.
L’Unità di strada è “un esserci” sulla strada, posizionarsi rispetto
a una specifica area di utenza. Il posizionamento esplicito su prevenzione Hiv, quindi su salute e vita, garantisce la possibilità di una relazione significativa
anche se “a legame debole”; definisce e struttura il
entrambi i soggetti da aspettative magiche e da svalutazioni infinite.