Lunedì, 12 aprile 2010 - 13:30:00
di Antonio Prudenzano
"Devozione",
dilaniante romanzo-reportage dell'esordiente 30enne Antonella Lattanzi (laurea in lettere moderne, oggi collabora con varie case editrici in veste di traduttrice, editor e correttrice di bozze), ha il merito di raccontare un inferno invisibile ai nostri occhi accecati e corrotti dalla superficialità:
quello dei "nuovi" tossici (le overdose sono in diminuzione, ma le epatiti C sono in drammatico aumento...). Sì perché la droga in Italia non si è mai data alla fuga. Al contrario, di anno in anno ha allargato i suoi orizzonti e scoperto nuovi target (dai pre-adolescenti ai manager). "Devozione" racconta il ritorno (quantomeno mediatico) dell'eroina ("In realtà mai scomparsa", ci ha spiegato l'autrice) e la diffusione delle nuove sostanze stupefacenti. Lo fa dall'interno di un limbo di giovani alla disperata ricerca della felicità, meta irraggiungibile, in un viaggio conturbante al termine dell'autodistruzione, che ha tre protagonisti principali (Nikita e Pablo, coppia di eroinomani, e Annette, bambolina francese vittima di un assurdo tentativo di rapimento), e una serie di comparse incapaci di liberarsi dalla dipendenza. Come Roberto Saviano, Antonella Lattanzi per scrivere il suo libro ha prima vissuto sulla propria pelle la realtà drammatica che ha poi messo su carta. Nell'intervista rilasciata ad Affaritaliani.it, l'autrice ammette di aver adottato lo stesso metodo e lo stesso approccio alla scrittura dell'autore di "Gomorra", di certo il meno comodo, e parla di quella che definisce una personale "fascinazione" per l'eroina, scoperta da ragazzina a Bari a metà anni '90...
Per scrivere "Devozioni" ha frequentato per anni i Sert (fingendosi tossica), i punti di ritrovo dei drogati del terzo millennio, le piazze dello spaccio, le comunità, in un inevitabile processo di immedesimazione con i giovani protagonisti del suo libro. Cosa l'ha spinto a farlo?
"La verità è che ho sempre voluto raccontare questa storia. Sin da piccola amavo scrivere, e sin da ragazzina devo ammettere di aver subito una fascinazione per la droga e l'eroina in particolare. Non ho però mai fatto uso di sostanze stupefacenti, meglio specificarlo. La mia droga è infatti sempre stata la scrittura. La passione per la letteratura mi ha salvato dalla droga e dalla morte ...".
E com'è nata questa sua pericolosa 'fascinazione' per l'eroina?
"Nella mia adolescenza a Bari con i miei coetanei mi ritrovavano in due piazze sempre affollate. C'erano i punk, i metallari, i discotecari e così via. E c'erano anche i tossicodipendenti. All'inizio, tutti i gruppi, indistintamente, guardavano ai drogati come a degli sfigati. Poi, i miei occhi da adolescente hanno assistito a un cambiamento: a metà anni '90 gli eroinomani sono improvvisamente diventatati trendy. E così, tanti adolescenti, senza più badare alle differenze di gruppo, andavano ad acquistare da loro la droga. L'eroina ha unito tipologie di ragazzi sulla carta completamente diverse. Quando negli ultimi anni ho studiato e approfondito il tema per scrivere questo libro, ho scoperto che in quel periodo questa trasformazione non è avvenuta solo a Bari, ma anche nel resto d'Italia".
Oggi si parla di un ritorno dell'eroina. E' davvero così?
"L'eroina non se n'è mai andata. Semplicemente si è abbassata l'attenzione mediatica. Il picco dei morti per overdose c'è stato nel 1996, furono circa 1500. Oggi, grazie ai Sert e alla somministrazione del metadone, gli eroinomani possono condurre una vita più normale, e questo è l'aspetto positivo. Ma ce n'è anche uno negativo: il metadone crea una dipendenza fisica più lunga dell'eroina, 8 giorni invece di 3. E poi, rispetto al passato, oggi esiste una vera e propria silenziosa epidemia di epatite C".
Lei ha avuto la possibilità di entrare in contatto con decine di tossicodipendenti. A nessuno ha detto la verità, e cioè che non era una drogata come loro?
"Solo a una ragazza con cui sono entrata in particolare intimità. Con lei si è creato un rapporto talmente profondo che non ho potuto mentirle".
Ma ha capito cosa spinge questi ragazzi a drogarsi?
"La loro non è quasi mai una scelta autodistruttiva. All'inizio anch'io ero piena di pregiudizi, e pensavo ai tossici come a dei morti viventi. Ma chi si fa di eroina non cerca la morte. L'obiettivo è liberarsi dal dolore. Gli eroinomani sono ipersensibili e incapaci di affrontare i problemi".
La sua scelta di immergersi nella realtà della droga per poi raccontarla è paragonabile a quella di Roberto Saviano...
"Il paragone è un po' forte, ma regge. Certo, va precisato che ci siamo occupati di temi diversi e che 'Gomorra' è molto più reportage del mio libro, che è soprattutto un romanzo. E' però vero che entrambi per scrivere abbiamo avuto bisogno di scoprire sulla nostra pelle il mondo che poi abbiamo messo su carta".
Antonella Lattanzi, nel suo futuro cosa c'é?
"Sicuramente i libri. Sto già pensando al secondo. Voglio cambiare tema. Forse parlerò del rapporto madre-figlia
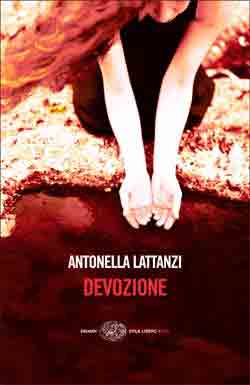 LA COPERTINA |
dilaniante romanzo-reportage dell'esordiente 30enne Antonella Lattanzi (laurea in lettere moderne, oggi collabora con varie case editrici in veste di traduttrice, editor e correttrice di bozze), ha il merito di raccontare un inferno invisibile ai nostri occhi accecati e corrotti dalla superficialità:
quello dei "nuovi" tossici (le overdose sono in diminuzione, ma le epatiti C sono in drammatico aumento...). Sì perché la droga in Italia non si è mai data alla fuga. Al contrario, di anno in anno ha allargato i suoi orizzonti e scoperto nuovi target (dai pre-adolescenti ai manager). "Devozione" racconta il ritorno (quantomeno mediatico) dell'eroina ("In realtà mai scomparsa", ci ha spiegato l'autrice) e la diffusione delle nuove sostanze stupefacenti. Lo fa dall'interno di un limbo di giovani alla disperata ricerca della felicità, meta irraggiungibile, in un viaggio conturbante al termine dell'autodistruzione, che ha tre protagonisti principali (Nikita e Pablo, coppia di eroinomani, e Annette, bambolina francese vittima di un assurdo tentativo di rapimento), e una serie di comparse incapaci di liberarsi dalla dipendenza. Come Roberto Saviano, Antonella Lattanzi per scrivere il suo libro ha prima vissuto sulla propria pelle la realtà drammatica che ha poi messo su carta. Nell'intervista rilasciata ad Affaritaliani.it, l'autrice ammette di aver adottato lo stesso metodo e lo stesso approccio alla scrittura dell'autore di "Gomorra", di certo il meno comodo, e parla di quella che definisce una personale "fascinazione" per l'eroina, scoperta da ragazzina a Bari a metà anni '90...
 Antonella Lattanzi |
"La verità è che ho sempre voluto raccontare questa storia. Sin da piccola amavo scrivere, e sin da ragazzina devo ammettere di aver subito una fascinazione per la droga e l'eroina in particolare. Non ho però mai fatto uso di sostanze stupefacenti, meglio specificarlo. La mia droga è infatti sempre stata la scrittura. La passione per la letteratura mi ha salvato dalla droga e dalla morte ...".
E com'è nata questa sua pericolosa 'fascinazione' per l'eroina?
"Nella mia adolescenza a Bari con i miei coetanei mi ritrovavano in due piazze sempre affollate. C'erano i punk, i metallari, i discotecari e così via. E c'erano anche i tossicodipendenti. All'inizio, tutti i gruppi, indistintamente, guardavano ai drogati come a degli sfigati. Poi, i miei occhi da adolescente hanno assistito a un cambiamento: a metà anni '90 gli eroinomani sono improvvisamente diventatati trendy. E così, tanti adolescenti, senza più badare alle differenze di gruppo, andavano ad acquistare da loro la droga. L'eroina ha unito tipologie di ragazzi sulla carta completamente diverse. Quando negli ultimi anni ho studiato e approfondito il tema per scrivere questo libro, ho scoperto che in quel periodo questa trasformazione non è avvenuta solo a Bari, ma anche nel resto d'Italia".
Oggi si parla di un ritorno dell'eroina. E' davvero così?
"L'eroina non se n'è mai andata. Semplicemente si è abbassata l'attenzione mediatica. Il picco dei morti per overdose c'è stato nel 1996, furono circa 1500. Oggi, grazie ai Sert e alla somministrazione del metadone, gli eroinomani possono condurre una vita più normale, e questo è l'aspetto positivo. Ma ce n'è anche uno negativo: il metadone crea una dipendenza fisica più lunga dell'eroina, 8 giorni invece di 3. E poi, rispetto al passato, oggi esiste una vera e propria silenziosa epidemia di epatite C".
Lei ha avuto la possibilità di entrare in contatto con decine di tossicodipendenti. A nessuno ha detto la verità, e cioè che non era una drogata come loro?
"Solo a una ragazza con cui sono entrata in particolare intimità. Con lei si è creato un rapporto talmente profondo che non ho potuto mentirle".
Ma ha capito cosa spinge questi ragazzi a drogarsi?
"La loro non è quasi mai una scelta autodistruttiva. All'inizio anch'io ero piena di pregiudizi, e pensavo ai tossici come a dei morti viventi. Ma chi si fa di eroina non cerca la morte. L'obiettivo è liberarsi dal dolore. Gli eroinomani sono ipersensibili e incapaci di affrontare i problemi".
La sua scelta di immergersi nella realtà della droga per poi raccontarla è paragonabile a quella di Roberto Saviano...
"Il paragone è un po' forte, ma regge. Certo, va precisato che ci siamo occupati di temi diversi e che 'Gomorra' è molto più reportage del mio libro, che è soprattutto un romanzo. E' però vero che entrambi per scrivere abbiamo avuto bisogno di scoprire sulla nostra pelle il mondo che poi abbiamo messo su carta".
Antonella Lattanzi, nel suo futuro cosa c'é?
"Sicuramente i libri. Sto già pensando al secondo. Voglio cambiare tema. Forse parlerò del rapporto madre-figlia

